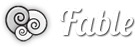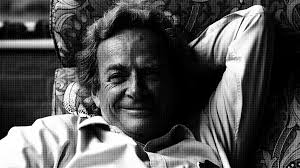“Il mondo è soltanto una scuola di ricerca.”
(Michel Eyquem de Montaigne)
Sono in molti, e io fra loro, coloro che amano non riamati la scienza. Se fino a qualche secolo fa era forse sufficiente una consolidata abitudine allo studio e alla lettura per tenersi aggiornati, da lunga pezza il sapere scientifico impone competenze che definire specialistiche è illusorio. Rileggendo questa frase mi scopro mentitore: non solo non capisco un acca della scienza contemporanea, ma pure le conquiste matematiche di Newton e Leibniz mi sono ostiche e oscure; e diciamo tutta la verità: pure sulle ellittiche di Keplero non sono a mio agio.
Quelli come me (spero vivamente siano moltitudine: amare la scienza sia pur senza comprenderla è un enorme passo avanti rispetto a chi idolatra statue sanguinanti) trovavano conforto e rifugio in S. J. Gould biologo, zoologo, paleontologo e storico della scienza statunitense la cui abilità di divulgatore scientifico forse supera la sua pur notevolissima statura di studioso e ricercatore. Gould, pubblicato in Italia da Feltrinelli a prezzi criminosi al punto da legittimarne il furto (l’ho già scritto e lo scriverò ancora e ancora) ha insegnato a leggere la storia dell’evoluzione del pianeta e delle specie in modo felicemente liberatorio: la scienza per chi la sa praticare è uno sport fonte di infinito piacere. Difensore civico della scienza e del pensare scientifico in un paese – gli Stati Uniti d’America – dove ogni due per tre il bifolco di turno sostiene che il creazionismo vada insegnato nelle scuole pubbliche, Gould si è impegnato in prima persona contro l’oppressione culturale delle pseudoscienze considerandole le naturali alleate del razzismo e di ogni forma di discriminazione.
Purtroppo Gould ha il grave difetto di essere morto. Altri Gould non mi risulta siano stati sinora scovati. Certo, di buona (a volte pure ottima) divulgazione scientifica ce n’è parecchia in giro. Ma la profondità del pensiero di Gould e la qualità della sua scrittura sono tutt’ora ineguagliate. Leggere Gould è come ascoltare una cantata di Bach; non è indispensabile la conoscenza della branca della scienza di cui sta narrando un episodio, così come non lo è la conoscenza del tedesco e del contrappunto per godere la compagnia del supremo Kapellmeister. Possiamo non sapere nulla di biologia evolutiva, geologia, matematica, paleontologia, ciò che conta è la curiosità e la voglia di sapere. Leggere i “casi” di Gould (come si è arrivati a determinare l’età della Terra nonostante tutte le zeppe infilate da religiosi e religioni, ad esempio) è infinitamente più avvincente dell’ennesimo racconto poliziesco.
Per mia fortuna l’altro giorno il sagace ufficio stampa dell’Adelphi mi ha “sollecitato all’acquisto” di un volumetto di Giorgio Vallortigara. S’intitola “A spasso con il cane Luna” anche se il cane Luna c’entra poco o nulla e comunque compare in un solo breve racconto. Ma se la passeggiata è breve, lo spasso inteso come piacere della scoperta è di lunga durata. Il Vallortigara è un neurobiologo che ha la maledizione della scrittura: è bravissimo, sicché con buona probabilità deve aver fatto qualche sconcia concessione al demonio in cambio di questa sulfurea abilità. Scrive bene e pensa ancor meglio. In ogni capitoletto di questo suo libro lavora instancabile come un tarlo sfatando riti e miti del nostro narcisismo onnipotente: davvero a un cervello più grande corrisponde necessariamente maggiore intelligenza? A proposito di discendenza, davvero non sapete che homo sapiens – il padrone e signore dell’universo mondo – condivide il 40% del dna con la banana? Siamo certi che solo noi umani siamo empatici? E se lo fossero anche le formiche? (eccetera eccetera). Ma attenzione: la conclusione che se ne ricava non è il solito guazzabuglio antiscientifico di scuola antispecista, tutt’altro. Qui il “pensare scientifico” percola in purezza come da un alambicco a ripasso: Vallortigara insegna che la scienza è l’arte del dubbio, e ogni dubbio risolto genera nuove domande e nuovi dubbi. Finchè il sole sarà acceso e noi (o chi per noi) avrà il piacere di pensare.
Un’ultima domanda: come si fa scienza? Una risposta ce la dà Richard Feynman, uno bravetto parecchio che ha amato e goduto la vita quanto la scienza:
“Ora vediamo come si fa a scoprire una nuova legge. In generale il procedimento è questo: per prima cosa tiriamo a indovinare, poi calcoliamo le conseguenze della nostra ipotesi per vedere quali circostanze si verificherebbero se la legge che abbiamo immaginato fosse giusta. Infine, confrontiamo i risultati con la natura, con gli esperimenti, con l’esperienza per vedere se funziona. Se non è in accordo con gli esperimenti, l’ipotesi è sbagliata. In questa semplice affermazione c’è la chiave della scienza. Non importa quanto sia bella la tua ipotesi, non importa quanto intelligente sia la persona che l’ha formulata o quale sia il suo nome. Se non è in accordo con gli esperimenti è sbagliata. Immaginate di aver ideato una buona ipotesi e di aver calcolato che tutte le sue conseguenze siano in accordo con gli esperimenti. Allora la teoria è giusta? No, non si è potuto semplicemente dimostrare che sia sbagliata perché in futuro ci potrebbero essere degli esperimenti che possano confutare la teoria. (…). Non possiamo essere sicuri di avere la teoria giusta, ma solo di non avere la teoria sbagliata”.